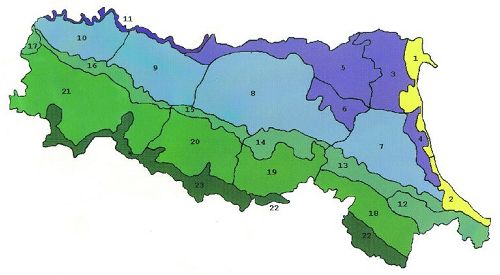
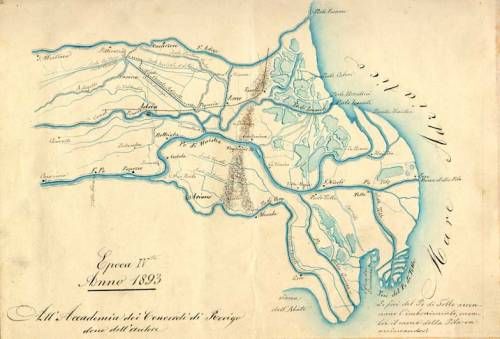
L’EVOLUZIONE DEL DELTA DEL PO
Tra i cinque ed i due milioni di anni fa, nel Pliocene, l’Italia era
una penisola estremamente diversa da quella di oggi. Gli attuali territori
pianeggianti non esistevano. Il Mare Adriatico sommergeva completamente
tutto il territorio della pianura padana mentre le sole terre emerse erano
i rilievi alpini e quelli appenninici.
Col passare del tempo l’insenatura corrispondente alla pianura padana
si riempì dei sedimenti detritici generati dall’erosione meteorica
delle catene montuose che la circondavano e negli ultimi 700.000 anni, grazie
anche all’abbassamento del livello del mare causato a sua volta da
alcuni cicli glaciali che portarono i ghiacciai ad espandersi sottraendo
acqua agli oceani, l’insenatura padana si colmò dei sedimenti
fino ad emergere al di sopra del livello del mare.
Durante l’ultimo periodo glaciale, ovvero il Wùrm, tra 75.000
e 15.000 anni fa, il livello del Mar Mediterraneo arrivò ad essere
addirittura di 100 metri inferiore rispetto a quello attuale ed il Po sfociava
in mare addirittura all’altezza di Pescara.
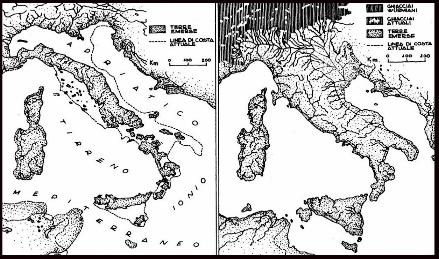
-------L'Italia durante il Pliocene ------------L'Italia durante l'era glaciale wùrmiana _(28)
Sul finire della glaciazione infine, attorno a 10.000-15.000 anni fa, un
ulteriore scioglimento dei ghiacci restituì acqua al bacino mediterraneo
e, all’incirca 5.000 anni fa, l’alto Adriatico venne di nuovo
completamente sommerso e portando la linea di costa a stabilizzarsi progressivamente
sull’attuale profilo.
In ogni caso la fascia litorale più recente, che abbraccia le aree costiere
tra Ravenna e Chioggia (VE), venne a costituirsi negli ultimi 2-3.000 anni,
grazie all’apporto di sedimenti portati dal Po e dai suoi rami. _(28)
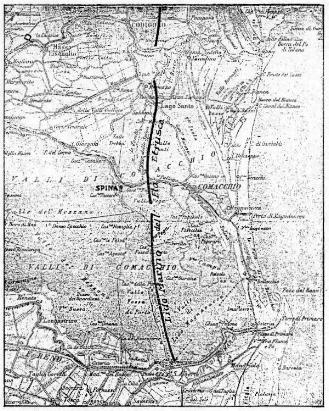
_(37)
I PRIMI INSEDIAMENTI
Il primo grande insediamento costiero formatosi nell’area ravennate-ferrarese
fu il centro greco-etrusco di Spina. Sorse all’incirca nel VI secolo
a.C. nei pressi dell’allora foce del Po.
Per diversi secoli Spina rivestì un importantissimo ruolo di interscambio
tra gli insediamenti costieri di tutto l’Adriatico e l’entroterra
padano. Successivamente però, a causa del progressivo alterarsi del
profilo costiero e delle invasioni galliche, perse progressivamente importanza
fino a scomparire.
In epoca romana, a partire dal I secolo a.C. cominciò l’ascesa
di Ravenna, grazie anche alla costruzione del porto di Classe voluto dall’imperatore
Ottaviano Augusto (63 a.C.–14 d.C.) per ospitare la flotta romana a
controllo del Mediterraneo orientale.
L’apertura delle strade consolari come la Via Popilia (in parte coincidente
con il tracciato dell’attuale strada statale Romea) e lo scavo di canali
come la Fossa Augusta che congiungeva il fiume Padoa con Ravenna diedero
un grande impulso all’agricoltura grazie al considerevole apporto di acqua
dolce, alla navigazione interna e quindi all’agricoltura ed al commercio,
in particolare del sale. _(28)
Durante il dominio dell’Impero Bizantino (395 d.C. – 1453 d.C.)
sulle nuove terre formatesi alla foce del Po di Volano sorse, da un primo
nucleo benedettino, l’Abbazia di Pomposa che rivestì un importantissimo
ruolo di centro culturale e religioso del medioevo, grazie soprattutto ai
monaci amanuensi che vi risiedevano. Costruita attorno al VI-VII secolo
d.C., venne consacrata dall’Abate Guido nell’anno 1.026. In quest'abbazia,
il monaco Guido d'Arezzo inventò le note musicali moderne.
A partire dall’anno 1000 Ravenna cominciò a perdere progressivamente
importanza, mentre contemporaneamente cominciarono ad assumere un ruolo
sempre più importante sia la città di Ferrara, conquistandosi
l’egemonia commerciale sui traffici delle vie d’acqua interne,
che il centro di Comacchio, grazie al porto ed alle saline delle sue valli,
che però ben presto a causa delle guerre con Venezia per il dominio
dei traffici commerciali costieri venne quasi completamente distrutta.
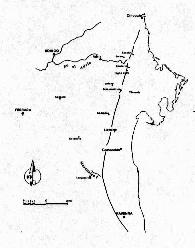 |
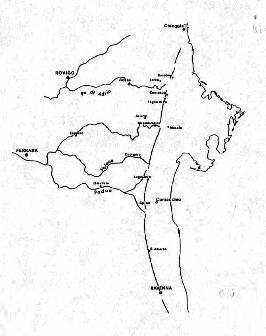 |
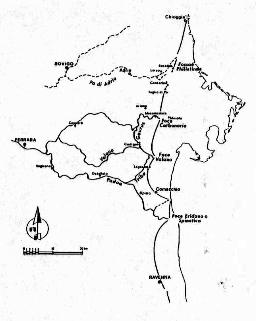 |
|
Età pre-etrusca
|
IV a.C
|
I-II a.C
|
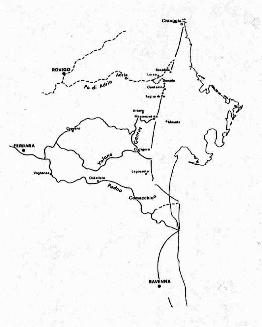 |
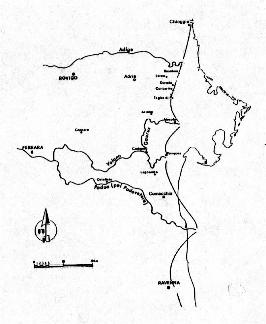 |
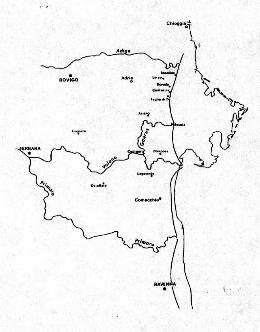 |
|
I-II d.C
|
VI d.C
|
IX-X d.C
|
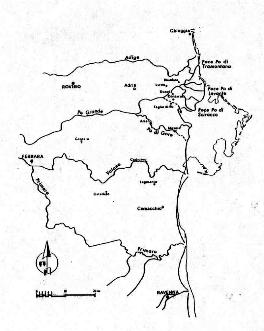 |
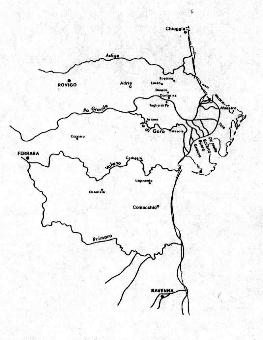 |
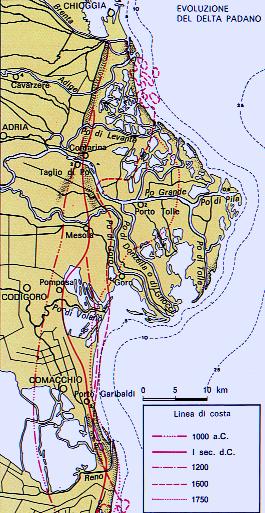 |
|
fine XVI d.C
|
1730 d.C
|
Successione temporale
|
La linea di costa del delta del Po negli ultimi 2.000 anni _(28) _(101)
LE BONIFICHE
Le prime bonifiche dei territori del basso ferrarese furono eseguite degli
Estensi attorno al XV d.C. Furono opere, per così dire, preliminari,
che introdussero poi, nella seconda metà del XVI, la grande bonifica
ferrarese del ‘500. Tale intervento se da un lato aumentò significativamente
la superficie coltivabile, dall’altro portò le popolazioni residenti,
a scontrarsi con le difficoltà inerenti la gestione degli argini
e delle “terre nuove”.
Subito dopo pochi anni cominciarono a manifestarsi significativi fenomeni
di subsidenza naturali che portarono al rapido riallagamento di vaste zone
bonificate, fino a che poi, nel 1599 ad opera della Repubblica di Venezia,
venne effettuata la deviazione dell’allora principale ramo del Po verso
sud (presso Viro), per scongiurare che i sedimenti fluviali che fino ad
allora venivano ridistribuiti dal mare lungo la costa adriatica nord ne
interrassero i porti. Quest’opera cambiò definitivamente l’assetto
idrogeologico dei territori circostanti e diede inizio allo sviluppo del
moderno delta del Po.
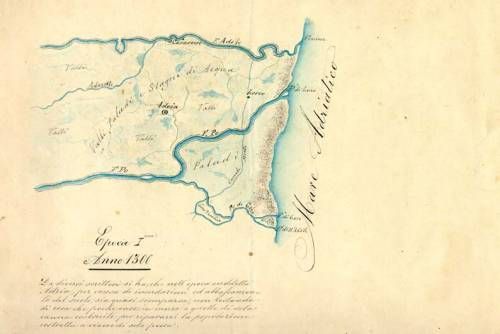 |
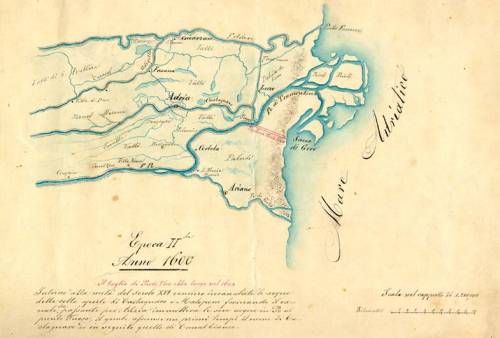 |
|
1300 d.C
|
1600 d.C
|
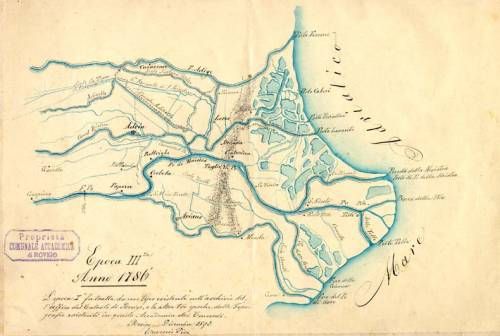 |
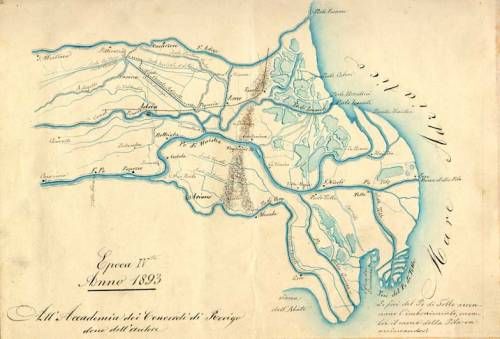 |
|
1686 d.C
|
1893 d.C
|
_(38)
Per fortuna, attorno alla metà del 1850 avvenne l’introduzione
delle macchine idrovore a vapore che consentirono di gestire in maniera
più organica ed organizzata i problemi idrogeologici del territorio.
L’ultimo capitolo, quello moderno, di questo lungo processo di bonifica
iniziò verso i primi del ‘900 e proseguì fino agli anni ’60: grazie ad esso,
attraverso un complesso sistema di scolo delle acque affidato a canali ed
impianti idrovori si giunse all’attuale distesa pressochè omogenea ed uniforme
distesa di terre coltivate. _(29)
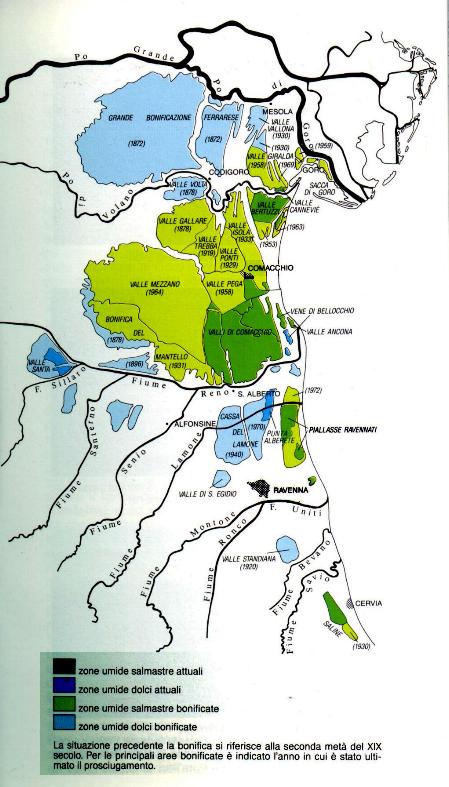
_(29)
Le bonifiche più importanti del ferrarese furono quelle delle valli
Mezzano, Trebba e Pega, mentre nel ravennate, poco più a sud delle
Valli di Comacchio, fu realizzato il Canale di Bonifica in destra di Reno,
che richiese l'impiego di migliaia di operai (fra cui i cosiddetti "scariolanti").
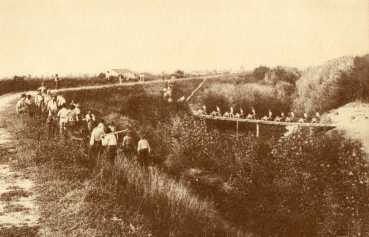 |
 |
_(109)
Oggi, in seguito all’eccessivo sfruttamento delle falde acquifere per uso
agricolo, industriale, potabile e metanifero, gran parte dei territori deltizi
si trovano al di sotto del livello del mare, a causa dell’accentuata subsidenza
indotta e del mancato apporto di sabbie fluviali. _(29)